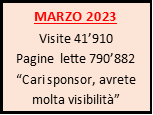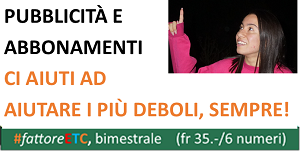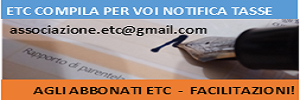Questa volta, cari lettori, vi voglio parlare, sia pure in poche righe, di un prodotto della tradizione della regione Friuli. Si tratta di un salume non salume, di un insaccato non insaccato. Sto parlando della “Pitina”. Come per molte altre specialità italiane anche per la Pitina dobbiamo tirare in ballo i tempi andati, quando la ricchezza non era di casa ma, al contempo, regnavano il buon senso e la cultura del non spreco.

Nelle valli a Nord di Pordenone durante i mesi freddi (autunnali e invernali) se si abbatteva un camoscio o un capriolo, se si feriva una capra o una pecora, era di fondamentale importanza non sprecare assolutamente nulla; bisognava pertanto conservarne le carni nel migliore dei modi. Ecco che nacque così dalle evidenti esigenze di conservazione e dalle più semplici origini contadine la Pitina e le varianti Peta e Petuccia. Varianti in base alle erbe utilizzate nell’impasto e nelle dimensioni per quanto riguarda la Peta. L’animale veniva disossato accuratamente le carni triturate finemente, venivano aggiunti sale, aglio e pepe nero. Nella Valle Tramontina, da dove ha origine la Pitina, si utilizzava anche il rosmarino, mentre in Val Cellina, per la Petuccia si aggiungevano le bacche di ginepro e il finocchio selvatico. La Peta, che poteva pesare anche un chilo, era localizzata nel comune di Andreis sempre nella Val Cellina.

La Pitina veniva prodotta in maniera molto semplice, si formavano con l’impasto ottenuto delle piccole polpette, si passavano nella farina di mais e si facevano affumicare al caldo del focolare. Dopo qualche giorno di asciugatura era dunque pronta per essere ammorbidita nel brodo della polenta e consumata. Era uno dei tanti prodotti che hanno rischiato di cadere nel dimenticatoio gastronomico fino a quando un piccolo gruppo di appassionati produttori non ha pensato bene di riproporla ai palati degli intenditori. La Pitina di oggi è ingentilita dalle carni di maiale (prevalentemente lardo e capocollo) che si accompagnano alla selvaggina, alla capra o alla pecora, ma richiede le stesse tecniche di lavorazione: il passaggio nel mais e l’affumicatura con il legno, il faggio in particolare.
Per gustarla ci sono vari modi, dopo 15 giorni di stagionatura la si può apprezzare semplicemente a fette come un qualsiasi salume, servita chiaramente con la polenta come da tradizione, scottata con burro e cipolle, accompagnata a formaggi del territorio e ancora cotta nel latte. Per l’abbinamento con il vino non c’è che da scegliere in una regione maestra nella produzione di vini bianchi pregiatissimi. Tra tutti perché non optare per un fresco Friulano (il vino che non possiamo più chiamare Tocai e che ha preso la denominazione di Friulano) con due fette di Pitina appena affettata?!?! Delizia per il palato a tutti gli effetti.
Se vi capitasse di andare da quelle parti per una vacanza, e ve lo consiglio spassionatamente, andate a gustarvi la Pitina dall’amico Danel a Cavasso Nuovo al ristorante “Ai Cacciatori” avrete modo di farvela servire in differenti tipologie di utilizzo in cucina, e poterete gustarvi la più tradizionale cucina del territorio. Se invece volete vedere dal vivo coma la si produce fate un salto nel comune di Tramonti di Sopra da Roberto Ferraro presso il suo agriturismo Borgo Titol, qui troverete i bovini, i suini, gli animali da cortile, un piccolo caseificio che realizza ottimi formaggi e, naturalmente, la produzione della Pitina. Roberto è uno dei pochi produttori di Pitina della zona e credo che sarà ben lieto di farvi vedere la lavorazione e, ancora meglio, farvi gustare il meraviglioso sapore.
Questo comprensorio territoriale fa parte delle Dolomiti Friulane, è una terra che si può godere sia in inverno che durante la bella stagione. Potrete spaziare dalla città storica della coltelleria Maniago con il suo bellissimo museo, ai mosaici di Spilimbergo; poi visitare Sequals città natale di Primo Carnera e soggiornare al Belvedere dove i vini li scegli tu direttamente in cantina. Poterete recarvi a Polcenigo per assistere allo spettacolo naturale delle risorgive o visitare il museo di arte cucinaria, le grotte e i siti preistorici di Clauzetto. Sempre per gli amanti della natura la possibilità di provare l’ebrezza del canyoning, la dolcezza delle acque del lago di Barcis o l’unicità dei Magredi: una situazione naturalistica unica al mondo. Inoltre assaporare il prosciutto di Aviano (un solo produttore) o i vini autoctoni di Emilio Bulfon: vi consiglio l’Ucelut. Andare a cena a Meduno al ristorante La Stella da Regis per gustare il gallo in tecia e vedere un vero “Fogolar Friulano” di un tempo. E poi, perché no, salire a Piancavallo dove lo sport è praticabile tutto l’anno. Un lembo d’Italia dell’est bello e storico, dagli scenari unici e dai sapori indimenticabili.
Fabrizio Salce