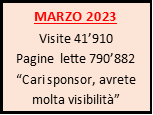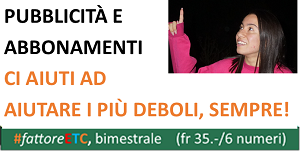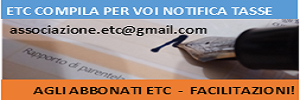LA POSIZIONE DELL’ITALIANO IN SVIZZERA:
UNO SGUARDO SUL PERIODO 2012-2020 ATTRAVERSO ALCUNI INDICATORI
Sintesi del rapporto di ricerca commissionato dal Forum per l’italiano in Svizzera
Forum per l’italiano in Svizzera
1. Contesto e obiettivi della ricerca
Il rapporto «La posizione dell’italiano in Svizzera: uno sguardo sul periodo 2012–2020 attraverso alcuni indicatori» risponde al mandato di ricerca che il Forum per l’italiano in Svizzera (di seguito nominato Forum) ha assegnato nel mese di luglio del 2019 a un consorzio di ricercatori dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI), del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (SUPSI-DFA) e dell’Alta scuola pedagogica dei Grigioni (PHGR).
L’insieme degli indicatori individuati permette di disegnare un quadro sfaccettato della posizione dell’italiano in Svizzera, in particolare fuori del suo territorio tradizionale (la Svizzera italiana) e rispetto a due momenti di riferimento: quello della fondazione del Forum (2012) e quello attuale (2019/20).
I quattro gruppi di indicatori presentano un’analisi diagnostica della situazione dell’italiano nel contesto del plurilinguismo svizzero considerando l’aspetto demografico e sociolinguistico (2), il ruolo dell’italiano come lingua ufficiale (3), la sua posizione nell’insegnamento (4) e la sua presenza nell’ambito culturale (5). Questi aspetti coprono a grandi linee le sfere d’interesse del Forum.
2. Indicatori demolinguistici
Gli indicatori demolinguistici fanno capo alle rilevazioni strutturali (2017 e precedenti) e all’indagine sulla lingua, la religione e la cultura (2014 e 2019) dell’Ufficio federale di statistica; sono uno strumento conoscitivo centrale per il monitoraggio della situazione dell’italiano e una precondizione indispensabile per attuare eventuali misure di promozione e sostegno delle lingue.
I dati relativi alla distribuzione territoriale dei parlanti mettono in luce un aspetto spesso enfatizzato nel dibattito pubblico: la maggioranza degli italofoni (ca. 53%) risiede al di fuori della Svizzera italiana, trovandosi pertanto in una situazione minoritaria senza particolare tutela e costituendo una comunità frammentata e trasversale, unita solo nella lingua.
Inoltre emerge l’incidenza del fattore migratorio (esogeno e endogeno) sulla presenza numerica e sulla diffusione dell’italiano soprattutto fuori territorio. L’immigrazione dall’Italia contribuisce a mantenere per l’italiano il rango di terza lingua principale più diffusa sul territorio nazionale.
Si nota inoltre un mantenimento, in una certa misura, dell’uso dell’italiano in ambito familiare e in misura minore sul posto di lavoro. La limitata acquisizione della lingua fuori delle mura domestiche è anche una conseguenza della politica educativa basata sul principio della territorialità.
Accanto alla lingua principale (8.4%), il 33% della popolazione in Svizzera dichiara di possedere una competenza parziale (lingua secondaria) dell’italiano a vari livelli. I repertori bi-plurilingui sono un’altra componente essenziale – e un potenziale – per il mantenimento e la diffusione dell’italofonia complessiva.
3. Gli indicatori della posizione dell’italiano come lingua ufficiale
3.1 La legislazione linguistica è in primo luogo uno strumento di politica linguistica, ossia una misura di intervento sugli equilibri fra le lingue. Allo stesso tempo, la presenza di una legislazione e la sua configurazione costituiscono un indicatore fondamentale della propensione delle istituzioni a intraprendere misure di promozione e/o di tutela delle lingue.
Dal punto di vista formale (legislativo) si può dire che l’italiano è una delle lingue nazionali minoritarie meglio tutelate al mondo; dal punto di vista funzionale (implementazione dello statuto e uso effettivo dell’italiano come lingua ufficiale) emerge invece una situazione sfaccettata. Questo aspetto è stato indagato nell’ambito dei processi politici e nell’amministrazione pubblica attraverso vari indicatori.
3.2 L’italiano come veicolo di comunicazione ufficiale: gli indicatori hanno evidenziato una grande differenza fra i generi di testo parlati e scritti. La funzione piena ed effettiva di lingua ufficiale si riscontra per l’italiano esclusivamente nei testi scritti come i comunicati stampa, i testi di legge e i testi delle offerte di lavoro. Nella comunicazione parlata (dibattito parlamentare negli anni 2012 e 2019) invece la presenza dell’italiano è quasi esclusivamente limitata a interventi di bassa valenza comunicativa.
3.3 La rappresentanza della comunità italofona fra gli impiegati nell’Amministrazione federale (AF), nei quadri degli enti parastatali e nel processo di reclutamento nell’AF: si constata una buona rappresentanza italofona se si considera il personale dell’AF nella sua totalità; le lacune emergono differenziando per dipartimento e focalizzandosi sulle fasce salariali elevate. Nei bandi di concorso si constata che non è generalizzata una strategia che esprime il particolare gradimento di candidature italofone (e in genere delle comunità linguistiche meno rappresentate). Nei quadri alti degli enti e delle istituzioni parastatali si osserva un aumento della rappresentanza italofona (il numero complessivo dei membri di direzione è per altro ridotto).
3.4 L’italiano come parte del capitale linguistico e come competenza individuale del personale dell’AF: nel repertorio linguistico collettivo dell’AF, l’italiano è presente come L1 in livelli simili alla rappresentanza della comunità italofona; le competenze come lingua non nativa, pur presenti, sono di livello notevolmente più basso rispetto alle altre lingue nazionali. Inoltre si è osservato che la totale assenza di competenze è tuttora ancora frequente anche nei livelli salariali più elevati, dove l’OLing prevedrebbe almeno competenze passive.
Sono però in atto interventi di politica linguistica dell’AF volti a promuovere le competenze d’italiano. La formulazione dei requisiti linguistici nelle offerte d’impiego rispecchia abbastanza fedelmente le disposizioni dell’OLing sia per quanto riguarda il bilinguismo funzionale in due lingue ufficiali (questo è un requisito che può essere considerato parte delle competenze professionali richieste al personale) sia per quanto riguarda la terza lingua ufficiale (l’italiano nella maggior parte dei casi). Inoltre le misure riguardanti la formazione linguistica del personale (potenziamento dei corsi) hanno favorito l’italiano (aumento degli iscritti) rispetto alle altre lingue. Tuttavia, oggi le competenze d’italiano del personale federale non hanno ancora raggiunto gli obiettivi previsti dall’Oling per un’effettiva comprensione reciproca fra le comunità linguistiche.
4. Gli indicatori dell’offerta di insegnamento dell’italiano
Il sistema educativo svizzero è caratterizzato da una forte autonomia cantonale in materia di educazione, ma il concordato HarmoS e una serie di ordinanze e regolamenti fissano alcuni requisiti comuni a cui i cantoni elvetici dovrebbero attenersi.
L’analisi ha evidenziato lacune legate alla carenza di dati disponibili e alla loro raccolta non sempre sistematica e standardizzata per tutti i gradi e gli ordini scolastici a livello svizzero.
Nelle scuole dell’obbligo – con l’eccezione dei Cantoni Grigioni e Uri – l’italiano è offerto solo a partire dalla scuola media, peraltro come materia facoltativa nella maggior parte dei cantoni o come materia opzionale a scelta per pochi cantoni. A discapito delle lingue nazionali, l’inglese è divenuta la seconda lingua di insegnamento obbligatoria in molti cantoni. Questo a fronte di una crescita negli ultimi anni della popolazione di allievi italofoni non scolarizzati in italiano. A livello post-obbligatorio è lacunosa l’informazione per la formazione professionale; i dati disponibili sono limitati al liceo e all’offerta, crescente, di percorsi bilingui francese-italiano e tedesco-italiano; percorsi che tuttavia avrebbero le potenzialità per riscuotere un successo maggiore.
A livello delle cattedre di italianistica in Svizzera la ricerca ha evidenziato l’aumento del numero di posti di seconda fascia a discapito di quelli di prima fascia. Tale tendenza va tuttavia contestualizzata con quella in atto per le altre lingue nazionali e per l’inglese.
I programmi di mobilità e di scambi linguistici (tra i quali Movetia) mostrano un’offerta ampia e differenziata di possibilità di studio dell’italiano; anche in questo caso non sembra però espresso tutto il potenziale. Ad esempio, negli scambi di classe le strategie attuate sembrano favorire soprattutto le altre lingue nazionali.
L’offerta di corsi di lingua e cultura italiana extacurricolari mostra una realtà molto diversificata. Tra i corsi più conosciuti e frequentati vi sono quelli di lingua e cultura dei paesi d’origine (LCO), che fanno segnare una riduzione importante (quantomeno a partire dal 2012) nel numero di iscritti e nel numero di corsi offerti.
In prospettiva sarebbe utile e interessante un approfondimento dell’insegnamento dell’italiano anche dal punto di vista qualitativo.
5. Gli indicatori della presenza dell’italiano nelle pratiche e nelle offerte culturali
Ogni lingua è veicolo di cultura e informazione. La ricerca ha indagato alcune pratiche della popolazione residente in Svizzera incentrate sulla fruizione e la produzione di contenuti culturali.
La lettura e la fruizione dei media radiotelevisivi e di internet risultano essere attività diffuse e importanti per il mantenimento di competenze dell’italiano fuori del territorio; in particolare per le persone che hanno l’italiano come lingua principale. Meno diffusa è invece la fruizione dei media in generale presso le persone per cui l’italiano è lingua secondaria. Anche in quest’ambito, è soprattutto questa categoria di persone che rappresenta un potenziale di diffusione della lingua; va notato che sono già disponibili programmi didattici e ci sono già enti che promuovono l’attivazione delle competenze ricettive d’italiano (per es. l’ente radiotelevisivo nazionale).
Riguardo alla produzione cinematografica si constata che in ogni regione linguistica domina la fruizione di film la cui lingua originale corrisponde alla lingua locale; fuori del territorio tradizionale i film in italiano sono visti da un numero ridotto di spettatori.
L’analisi della fruizione di contenuti museali evidenzia che solo un quinto dei musei a vocazione sovraregionale e con sede al di fuori del territorio italofono dichiara di accogliere i visitatori in italiano. Solo circa un quarto di questi dispone di un sito internet con una versione parziale o totale in italiano (questo non esclude che ci sia un’accoglienza in italiano in loco).
6. Conclusioni e prospettive
Le valutazioni puntuali sulla situazione demolinguistica dell’italiano, del suo ruolo come lingua ufficiale, dell’offerta di insegnamento, della sua presenza nell’ambito culturale hanno evidenziato sia i punti di forza sia alcune situazioni problematiche. Laddove l’analisi ha rivelato carenze e/o ha permesso di individuare opportunità di interventi, sono stati formulati suggerimenti o proposte.
Gli indicatori permettono di delineare un quadro differenziato della collocazione dell’italiano in Svizzera nei vari ambiti. Se da un lato, non è sempre possibile individuare relazioni dirette tra misure e iniziative di promozione linguistica (soprattutto sul breve termine), dall’altro risulta evidente come una buona base conoscitiva e il monitoraggio costante della situazione siano prerequisiti essenziali per le azioni di promozione della lingua. Da questo punto di vista, la ricerca incentivata dal Forum ha permesso di individuare una prima ampia e sistematica serie di indicatori aggiornabili e di facile reperimento. Questi costituiscono un punto di partenza per possibili sviluppi dell’indagine, un invito a mantenere viva l’attenzione sulla situazione della terza lingua nazionale e un incentivo per nuove iniziative di promozione del plurilinguismo federale.